#articoli
L'occhio che uccide: chi troppo vede il nulla stringe
Una re-visione in tre frammenti
Parecchio è stato scritto su L'occhio che uccide, tanto che sono celebri le fluttuazioni nella ricezione critica dell'opera che ha affossato, di fatto, la carriera di Michael Powell.
Parecchio è stato scritto e spesso, per ragioni che possono sembrare ovvie, le pagine sono state inondate dall'inchiostro della psicologia e della psicanalisi, dalle ragioni della psiche.
Forse però l'occhio che uccide non uccide a causa della psiche malata che lo manovra, checché reciti la vulgata.
[Il trailer de L'occhio che uccide]
Per tentare un'interpretazione non-autorialista, alcune parole dell'autore possono, quasi per paradosso, offrire una traccia.
Dice Powell: "Io non sono un regista con uno stile personale... Io sono il Cinema.
[...] E solo qualcuno come me può fare L'occhio che uccide, perché è necessario identificarsi di più con il Cinema che con un mondo personale".
Poiché L'occhio che uccide disseziona la visione cinematografica, peraltro senza sconti nei confronti dello spettatore, dipaniamo l'interpretazione di un testo così frequentato anzitutto per spizzichi e bocconi, con piglio indiziario, proponendo alla lettura degli esercizi di re-visione, ovviamente interpretati dalla parola scritta.
Primo frammento.
Nella prima sequenza, che segue le riprese di un occhio che si spalanca non secondo il suo tempo naturale (ma con un'evidente velocizzazione del solo movimento di apertura meccanizzato) e che delinea un'atmosfera che sconfessa ogni realismo, nei toni sgargianti dell'Eastmancolor così come nella composizione scenografica, plastica al punto da collocare una prostituta dinanzi a una vetrina zeppa di manichini, vediamo un uomo.
Vediamo colui il cui occhio si è (o è stato) appena schiuso e colui che presto dirà – soltanto per finta? – di essere al soldo del The Observer, e lo vediamo nascondere una cinepresa per avvicinarsi alla prostituta, la sua prima vittima.
Lo cogliamo di spalle, e per una manciata di minuti, sin dopo i titoli di testa, non ne scorgeremo il viso, quello che Carl Boehm presta al protagonista, Mark Lewis, un assistente operatore, un omicida, il colpevole subito rivelato per spostare l'attenzione sul come estetico.
L'uomo nasconde la cinepresa sotto il cappotto.
Per la prima e unica volta questa riprende senza che Mark la regga con due mani e – insieme – senza che vi guardi attraverso; per la prima e unica volta non la tiene davanti agli occhi e non la controlla con precisione.
È – propriamente – una candid camera da cui sarebbe lecito aspettarsi immagini sporche, rubate; soprattutto, immagini massimamente tecniche, la cui visione non tenda a replicare quella dell'operatore.
Il passaggio alla soggettiva (?) del cine-occhio, interno allo spazio-tempo diegetico e contrassegnato da un mascherino che sbozza quasi una finestra, non conferma tuttavia le aspettative. Dopo essere stati inghiottiti dal nero dell'obiettivo, la pseudo-soggettiva appare troppo simile a una tradizionale soggettiva umana, sostituta degli occhi di Mark (che continua a muovere liberamente una mano) in termini di altezza e di movimenti.
Nulla spiega la variazione, tanto più considerando come i due long take non concedano ellissi.
Rimane solo, in questo curioso gioco di prospettive, di soggettive e oggettive, di umano e inumano, quel buio che sembra anticipare l'accesso alla scatola blu in Mulholland Drive.
[Un frame da L'occhio che uccide]
Secondo frammento.
Dopo aver incontrato di persona (e non protetto da una finestra-schermo) l'innocente Helen, affittuaria che dimora nella stanza della defunta madre, Mark la introduce di colpo nel suo buio regno, quella camera oscura che ha un carattere quasi uterino e che rimanda – in questo senso – al mantello-sottana della macchina fotografica impiegata in precedenza.
È uno spazio accogliente per il padrone (de iure) di casa ma non per la neo-ventunenne: fatto l'ingresso nel reame delle ombre cinematografiche, la giovane non può che notare quanto l'ammasso di apparecchiature sia terribilmente tecnico.
Nel buio Mark rivela l'origine del (proprio) male, più allo spettatore che all'ignara interlocutrice; rende noto l'Ur-trauma non tanto descrivendo un episodio biografico, ma anzitutto mostrando una prova inconfutabile: le immagini documentarie di cui è stato oggetto (e da cui è stato reso oggetto) durante l'infanzia, per mano del padre biologo.
Il ricercare dello studioso della vita aveva prodotto un'indagine della crescita del figlioletto, annullandone ogni privacy, al punto da riprenderne l'ultimo saluto alla madre sul letto di morte.
Mascherato dal distacco scientifico, lo studio rigoroso si fa così latore cieco di un sadismo che s'incide – nel passato come nel presente – sull'oggetto della visione.
Ma le ragioni della scienza sono sufficienti?
In chiusura di sequenza Helen sentenzia con sarcasmo sulla discrepanza tra mezzi e fini: in che modo da quell'operare potrebbe mai sorgere un esito felice?
Forse il problema – aggiungiamo – riguarda proprio la distinzione di mezzi e fini.
I filmati hanno però dell'altro da dire.
Anzitutto sul versante diegetico: nel contesto di una collisione temporale che la re-visione delle immagini concretizza, Mark reagisce in maniera singolare all'indecente documentazione dell'addio alla salma materna. Nel passato diegetico, il bambino (interpretato dal figlio di Powell) sta per toccare la mano della madre; taglio: nel presente diegetico, l'adulto tocca effettivamente la spalla di Helen.
Nella concatenazione del presente filmico, Mark sta rispondendo a un'assenza, alla perdita che – dirà lui stesso – ogni ripresa, ogni immagine catturata, infine determina: pur incidendo nel momento della propria realizzazione e, per di più, dinanzi al quadretto funebre, l'indagine scientifica del bio-logo non può che celare la vita da cui germoglia.
È da questa mancanza, perpetuata dalla re-visione del passato filmato, che Mark s'arresta in una postura contemplante di cui comprende nitidamente, e tragicamente, il desiderio violento (che difatti concretizza, senza peraltro curarsi troppo dell'intervento della Legge, preoccupandosi invece del come).
La natura cinematografica dell'Ur-trauma oltrepassa tuttavia il piano diegetico.
In primo luogo, perché il Padre è (interpretato dal)lo stesso Powell, che a tutta prima appare fuori fuoco e che dona al Figlio la cinepresa, il cine-occhio.
In secondo luogo, e nel profondo, perché le riprese del primo atto di voyeurismo del Figlio, che si appaiano alla simultanea scopofilia esercitata dal(la cinepresa manovrata dal) Padre, tradiscono – magari oltre le intenzioni del regista – una sintassi non-documentaria.
Proprio mentre Mark scavalca il muretto per poter spiare dall'alto, le immagini eccedono il modo osservativo e le giustificazioni narrative: in un banalissimo raccordo, il cine-occhio si fa improvvisamente ubiquo per catturare nella propria rete i due lati della cinta (e – con Jean-Pierre Oudart – per suturare il protagonista).
Ma non si badi troppo alle incongruenze in quanto tali: se il Padre è Powell, il Padre è invero il Cinema, la visione tecnica.
La parabola di Mark, soprattutto nel suo come, addita perciò un campo di problemi che non si risolve – si vedrà – nell'etica psicologistica (ossia nella morale) dello sguardo.
[Un frame da L'occhio che uccide]
Terzo frammento.
Dopo il rinvenimento della seconda vittima, interruzione di una sessione di riprese in cui il regista aveva imposto di recitare anche in assenza di sentimento, dacché la produzione deve andare avanti; dopo che, convocata la Legge, Mark ha quasi rotto sonoramente, facendo cadere penne e matite, la sua condizione di osservatore silenzioso manifestando così la vita dietro il cine-occhio, Helen legge dell'accaduto su un quotidiano e lo comunica alla madre cieca, alquanto sospettosa, chissà perché, nei confronti del cineoperatore.
D'un tratto, mentre discorrono, la madre percepisce la presenza di Mark, appostato dietro la finestra; è – per la precisione – il retro del suo collo, la parte del corpo di cui si fida, da cui parla, ad averlo sentito. L'uomo entra allora in casa e un'insolita transizione, dopo un breve colloquio con Helen, lo accompagna nel soggiorno: un velo si leva dal cine-occhio in oggettiva e Mark, sinora sorridente, adocchia corrucciato la signora Stephens.
I due si stringono la mano, ma la donna non molla la presa: sente la tensione dell'omicida, il battito cardiaco che accelera e che diviene, per le orecchie dello spettatore, il sottofondo sonoro dell'incontro.
Il punto cieco della visione ha dunque accesso, dopo lo svelamento, a una dimensione corporea, emotiva, dalla quale Mark è invece dolorosamente (e consapevolmente) escluso.
Del resto, quanto il cine-operatore sente – afferma un paio di minuti dopo – non può che essere fotografato, re-immesso nell'orizzonte della tecnica moderna, il luogo in cui L'occhio che uccide si aggira essenzialmente.
Che cosa paiono dire, infatti, i tre frammenti all'unisono?
Senza che il senso possa essere esaurito, il caleidoscopio metacinematografico di Powell (pardon: del Cinema) rende palpabile l'azione cieca, iper-vedente, violenta, maschile, assoggettante e astraente della tecnica moderna, avvistandone un lato che non chiude certo la questione ma scansando – quantomeno nelle suggestioni più dirompenti – ogni umanismo, ogni psicologismo, ogni moralismo
La tecnica orienta Mark, perennemente al lavoro, e non si lascia manovrare a fin di bene; è – allargando il discorso – al di là del bene e del male. Non è un mezzo da poter sottomettere ai propri fini morali; non è – testimone la prima sequenza – un che di inerte, un oggetto controllato dal soggetto; è semmai un orizzonte che inaugura delle occasioni e ne sopprime altre: tenta di cancellare la situazione corporea (non-materiale) e la situazione emotiva (non-psicologica) ma proprio lì si incide e si esprime, sul corpo e sull'emozione, ossia sull'ethos, sulla postura.
Mark Lewis è così la postura della tecnica moderna, la sua traccia, il suo come; e su quel come lavora, entro quell'orizzonte, alla stregua dell'estetica di Powell.
In questa direzione, se L'occhio che uccide è un esercizio (est)etico prima che un'elucubrazione intellettualistica, è – infine – perché prova a farsi carico, inceppando la visione consueta, del punto cieco delle nostre immagini.
___
CineFacts non ha editori, nessuno ci dice cosa dobbiamo scrivere né come dobbiamo scrivere: siamo indipendenti e vogliamo continuare ad esserlo, ma per farlo abbiamo bisogno anche di te!
Chi lo ha scritto

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
Lascia un commento

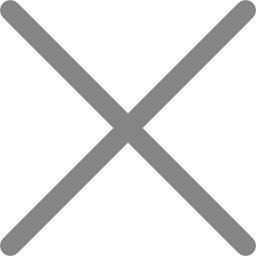
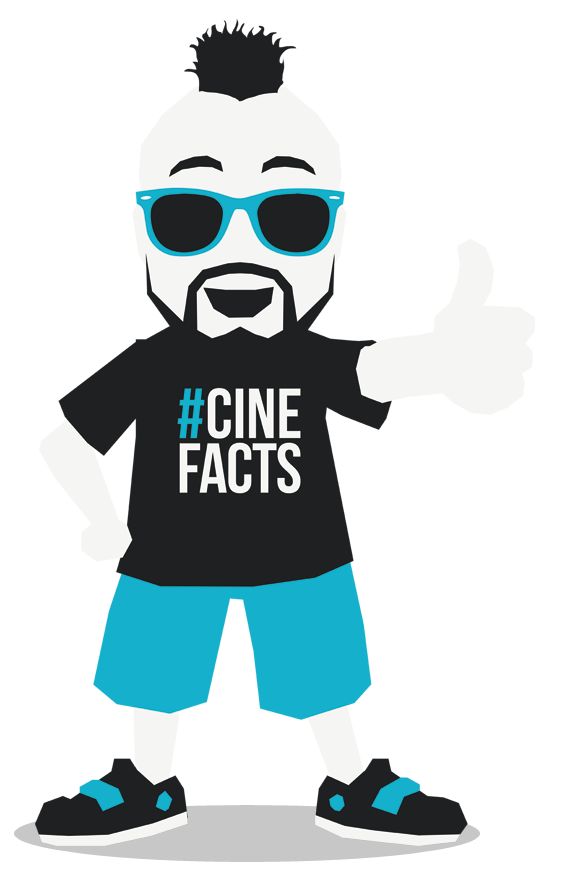

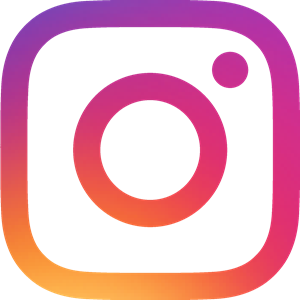






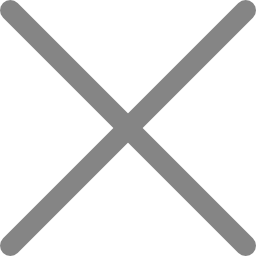
 Commentare gli articoli
Commentare gli articoli