#articoli
Eyimofe, Regina, Camp de Maci, Hochwald - Torino Film Festival 2020
Terza e ultima tranche di film in concorso al 38° Torino Film Festival
Ecco gli ultimi quattro film della selezione principale di questo 38° Torino Film Festival.
Una selezione di livello che si conferma, arrivati alla sua conclusione, di livello alto e forse superiore a molte delle scorse edizioni.
È presto per dire se siamo di fronte a esordi paragonabili ai grandi del passato, citati in precedenza negli articoli dedicati al Festival, ma senza dubbio il livello medio e la maturità di alcune delle opere stupiscono in relazione a edizioni con ben più fondi e in situazioni meno complicate.
Spiccano senza dubbio, ai miei occhi, Sin señas particulares e Moving On, subito dietro titoli come Camp de Maci e Wildfire che convincono molto, ma alle loro spalle davvero tanto Cinema di qualità e con idee.
_________________________
Eyimofe (This is My Desire)
di Chuko e Arie Esiri
La Nigeria è uno dei mercati cinematografici più prolifici in assoluto, come ci ha raccontato "l'avvocato dei creativi" Claudia Roggiero nel suo articolo, ma pur essendo un panorama cinematografico così fertile raramente raggiunge il mercato occidentale e i nostri festival.
Eyimofe, presentato anche alla Berlinale di quest'anno, ha prima di tutto un grande merito: raccontarci un mondo che ci sembra lontano e imperscrutabile, ma che in realtà è molto più vicino e simile di quanto non si creda.
Co-diretto dai gemelli Esiri, Chuko e Arie, il film è la perfetta rappresentazione di due punti di vista - simili, ma non sovrapponibili - sullo stesso tema e che, a un certo punto, finiscono per intrecciarsi.
[La città di Lagos mostrata in Eyimofe]
Il film è diviso in due storie e un epilogo.
La prima racconta le vicende del tuttofare Mofe che sogna di poter partire e cercar fortuna in Europa: ha già il passaporto e i soldi della sorella con cui convive sono già pronti per finanziarlo.
La sua serenità è però sconvolta dalla tragedia che in certi luoghi sembra essere un fantasma con cui fare i conti ogni giorno: una stufa appena aggiustata, ma caricata con benzina a basso costo, uccide nel sonno la sorella e i due nipotini che non si sveglieranno dopo una fredda notte nigeriana.
La seconda è la storia di Rosa, che vive nel grande centro di Lagos, tra i tanti lavori ed espedienti per cercare di emanciparsi da una condizione di vita pessima: la povertà al confine con i grandi hotel della quarta città africana per grandezza.
Qui, tra aguzzini proprietari di casa, grandi ricchi occidentali e guerre tra poveri ci viene mostrata la condizione di una donna in una città che dovrebbe rappresentare il progresso, ma che finisce per essere il simbolo di tutta la bestialità umana.
[Il protagonista della prima storia: Mofe]
Dopo una serie di sventure e tentativi di rilancio, tutto si conclude in un epilogo in cui le due vite si incontrano e i sogni di entrambi sono messi di fronte alla prova della realtà.
Un film che - anche grazie all'uso del 16mm - è in grado di affascinare in una selezione di opere prime dove inevitabilmente si predilige il digitale.
L'utilizzo della pellicola è ben sfruttato nella sua resa cromatica, e risulta profondamente reale - a tratti quasi documentaristico - nel suo modo di mostrare la difficile realtà che i due protagonisti si trovano ad affrontare.
La narrazione di Eyimofe si insinua in una società fatta di consuetudini, rapporti umani, debiti e favori da chiedere e riscattare: un mondo in cui la legge sembra un lontano miraggio che entra in scena solo per complicare le cose e in cui le grandi aree di grigio - tra il giusto e lo sbagliato - sono la quotidianità da affrontare.
Interessante notare come Eyimofe, per alcuni aspetti, si riallacci al film in concorso più lontano per contesto geografico come The Evening Hour, una produzione statunitense.
[La giovane sorella incinta di Rose]
Per raccontarci questo mondo, i gemelli Esiri si affidano principalmente ai piccoli oggetti e dettagli (come i salvagenti utili a tenersi a galla), nonostante la sfiducia che alcune situazioni potrebbero suggerire.
Il tentativo di concentrarsi sull'elemento minuto sembra quindi l'unico modo per sopportare le angherie che entrambi i protagonisti continuano a subite.
Piccoli oggetti come quelli che ripara Mofe in opposizione alle grandi cifre, siano esse in naire o in dollari americani, che vengono richieste e cercate affannosamente. La presenza costante del denaro è uno dei fattori più interessanti del film: sia nel rapporto che costruisce con la corruzione e la burocrazia, sia nel modo in cui il denaro rende l'uomo una bestia senza scrupoli.
I due registi sono poi bravissimi nel costruire un mondo reale che - nonostante la lontanza geografica - risulti universale nel suo racconto dei comportamenti umani: una carrellata di personaggi che cercano di trovare un modo per sopravvivere e che sono obbligati ad arrangiarsi, siano essi esempi positivi o negativi.
Un mondo in cui il sogno è rappresentato dall'occidente, dai suoi smartphone, le sue televisioni funzionanti e i veri tavoli da ping-pong, ma che in fondo non è così diverso dalla voglia di emancipazione sociale che il Cinema ci ha spesso raccontato.
[il capo di Mofe poco prima di licenziarlo]
Viene poi accennato un interessantissimo discorso sulle differenti prove - seppur nelle stesse miserie - che sono obbligati a sopportare una figura maschile e una femminile e su come l'occhio di una società, che ci ricorda tantissimo la nostra, giudichi diversamente i due sessi.
In questo contesto si inserisce tutta la sottotrama della gravidanza della sorella di Rosa, della vendita del frutto del proprio corpo e della naturalezza con cui un uomo di potere, come il proprietario di casa, cambi modo d'agire nei confronti della protagonista femminile.
Un film ottimo nel costruire le disgrazie che una a una si susseguono nelle vite di Mofe e Rosa, pienamente riuscito nel racconto relativo al peso che certe radici marce hanno in Nigeria, ma che sembra perdersi (purtroppo) nel grande schema dell'opera unitaria, risultando incostante nell'impianto drammaturgico e nel coinvolgimento emozionale.
Eyimofe è un'ottima opera prima, in cui si percepisce nella gestione la dimensione ancor presente del cortometraggio, ma che senza dubbio ha molto da raccontare e ottime idee sul come farlo.
_________________________
Regina
di Alessandro Grande
Regina, opera prima del calabrese Alessandro Grande, già vincitore del premio per il Miglior Cortometraggio ai David di Donatello del 2018, è il film italiano del concorso principale del Torino Film Festival.
Regina, omonima protagonista del film, figlia di un ex-musicista che ora puilisce piscine, sogna di fare la cantante.
La ragazza ci viene presentata mentre si esibisce con la sua chitarra azzurra (colore che ritorna per tutto il film) e, sin da subito, sappiamo che è brava e che "aprire il concerto di Brunori" è la possibilità che può cambiarle la vita.
Tutto, nelle azioni del padre (Francesco Montanari) - premuroso ma incalzante - è teso a questo sogno che viene visto come occasione di riscatto per entrambi e che lui vive come unica ragione della propria esistenza.
Non serve citare i temi classici di un padre che proietta sulla prole le proprie ambizioni perché conosciamo già questo tipo di racconto e non ci stupiamo nel vederlo riproposto ancora una volta in Regina.
La vera forza del film di Alessandro Grande - anche in questo primo aspetto più classico e noto - è la capacità di rendere tutto immediatamente ed estremamente chiaro e forte, anche grazie alle sue scelte di composizione dell'immagine.
Tutte le componenti che lo spettatore deve portarsi dietro da questa prima parte del racconto sono ben rappresentate dalla forma narrativa scelta dal regista: l'instabilità costante della situazione e di Regina, la scintilla che la cantante provoca nei suoi spettatori, una leggera morbosità nell'amore del padre e la sua tendenza ad agire nell'ombra.
[Regina e Luigi, padre e figlia]
Poche scelte che bastano al regista calabrese per trasmettere perfettamente l'anima del film: un leggero "respiro" di alcune inquadreature, un lungo e carico movimento in mezzo al pubblico, alcune scelte di composizione un pochino più ardite e tanti altri piccoli dettagli che nobilitano un contesto narrativo - della prima sezione del film - molto classico.
Sembra tutto ben confezionato, ma leggermente ingenuo, finché non arriva il vero colpo di coda narrativo che dona al film tutt'altra valenza.
Il giorno dopo il concerto della ragazza Regina e Luigi escono a pescare in un lago in cui non si potrebbe, un'innocente sgarro alla legge che hanno già fatto decine di volte: lo specchio d'acqua è infatti un luogo dove sentirsi liberi e in cui avere la certezza di non incontrare nessuno che possa disturbare i loro momenti padre-figlia, proprio grazie alle leggi che stanno infrangendo.
Rientrando a riva, il padre appaga la volontà di guidare la barca della figlia, propria di ogni quindicenne e simbolo di una maturità troppo anticipata, lasciandole il timone.
Poco dopo, un rumore sordo riporta entrambi alla cruda e violenta realtà: hanno travolto un sommozzatore e sono certi di averlo ucciso.
Non doveva essere lì e il padre è certo che ormai sia morto e che non si possa più fare nulla, così scappano negando all'uomo un soccorso che, si scoprirà in seguito, sarebbe stato salvifico.
[Poco prima dell'incidente]
La vita familiare è sconvolta in un istante, da una decisione infelice simbolo di tutto ciò che il loro rapporto già rappresentava.
Un mondo, quello del film Regina, in cui la casualità domina incontrastata, perfetto doppio del mondo in cui sogna di entrare la protagonista.
Da qui inizia un viaggio, che sembra uscito dal mondo di Edgar Allan Poe, in cui il senso di colpa di Regina la guida a inserirsi nel vuoto lasciato dal sommozzatore: inizia a frequentare la famiglia del morto come babysitter del figlio e aiutando la madre incinta.
Regina entra nella casa dell'uomo che ha ucciso per cercare di liberarsi dal ricordo indelebile di aver spezzato una vita, ma si ritrova a vagare affascinata da una figura materna assente nella sua vita e da un contesto familiare normale e amorevole che lei sente di aver distrutto.
Qui viene a contatto con il motivo per cui l'uomo che ha ucciso era immerso nel lago: vendeva reperti archeologici a facoltosi malavitosi.
Nel torbido di un contesto criminale che torna a pretendere ciò che è suo da una famiglia che non sapeva degli affari del padre - come nella più classica delle tragedie greche - si dipana una sottotrama crime non invadente e a tratti ben gestita.
Il centro del film, però, resta il viaggio di Regina: il nostro continuo seguire la macchina da presa - spesso a mano - ci permette di accompagnare il percorso di una ragazza venuta a contatto con qualcosa di troppo grande per lei, perfetto simbolo di quello che poteva essere una carriera musicale precoce e frutto degli accordi del padre.
Regina è un film che alterna grandi idee di messa in scena e scelte di simboli a momenti in cui le stesse risultano leggermente più ingenue e scontate.
Una produzione in cui alcuni filoni tematici sono sicuramente meno riusciti di altri: penso ad esempio alla rappresentazione del contesto scolastico, nel quale una certa banalizzazione e una minor qualità interpretativa dei suoi attori depotenziano quella che poteva essere un'ottima aggiunta al film.
Regina resta però un'opera prima solida, nonostante le sue imperfezioni e una gestione non sempre perfetta dei rapporti tra le varie sottotrame, audace nell'arduo compito di mostrare una voce personale che sappia prendersi i suoi spazi e impreziosita da un'incredibilmente brava Ginevra Francesconi, già vista ne Il Nido.
_________________________
Camp de Maci (Poppy Field)
di Eugen Jebeleanu
Camp de Maci di Eugen Jebeleanu, regista teatrale e attore romeno, è probabilmente il film più intimo della selezione di questo 38° Torino Film Festival: un'opera prima che racconta il dramma di essere omosessuali oggi in Romania.
Tutto nasce dalla rielaborazione di un evento di cronaca legato proprio al mondo del Cinema: nel 2018 a Bucarest alcuni manifestanti legati ai movimenti nazionalisti e di estremismo religioso hanno fatto fermare le proiezioni di 120 Battiti al minuto e Soldiers: Story from Ferentari esponendo insegne striscioni.
Cristi, il polziotto protagonista, è gay e sta ospitando in casa per alcuni giorni il fidanzato musulmano Hadi, che lo ha raggiunto dalla Francia, ma deve iniziare il suo turno di pattuglia e si ritrova nei tumulti legati alla proiezione di film a tematica LGBTQ+.
Il rapporto tra i due (e del protagonista con la sua sessualità) è subito ben raccontato nei primi minuti del film: il compagno Hadi ha accettato il proprio orientamento sessuale, così come la differenza religiosa tra i due.
Proprio per questo non ha difficoltà a interfacciarsi con la sorella di Cristi che è andata a trovarli, mentre il poliziotto invece si vergogna e cerca in ogni modo di metter fine a quella visita.
Questo è un primo e fondamentale momento nel quale si nota la difficoltà del protagonista a immaginarsi in pubblico con Hadi e in cui la conflittualità con la sorella - che definirà esplicitamente l'omosessualità del fratello come "una fase" - sono preludio al viaggio interno a Cristi, vero obiettivo del film.
[Hadi e la sorella di Cristi]
Dopo questa prima fase in cui già si esplicita tutta la refrattarietà del protagonista a mostrare la propria sessualità, il film si sposta completamente nel piccolo cinema in cui si svolgerà la gran parte degli eventi del film.
Qui il regista romeno è bravissimo a portarci immediatamente nel contesto caotico che si viene a creare: da un lato i manifestanti bigotti con le loro icone che aggrediscono verbalmente gli spettatori, dall'altro la rabbia di coloro che volevano solo vedere un film e che, poco a poco, capiscono che la proiezione non riprenderà, realizzando loro malgrado di vivere in un Paese profondamente retrogrado.
Tra i due schieramenti si trovano schiacciati i poliziotti, di cui fa parte Cristi: nel breve viaggio in macchina fino al cinema ci vengono presentati in tutto il loro tossico machismo, molto più vicino alle becere rimostranze dello schieramento dei manifestanti piuttosto che ai sentimenti di disagio del pubblico in sala.
[Cristi e l'ex-partner trovato nella folla]
Nella folla Cristi riconosce un uomo con cui aveva avuto una relazione precedentemente e che, di conseguenza, conosce il suo segreto di cui i colleghi sono all'oscuro.
Trovatosi isolato con lui, di fronte all'esuberanza e alla rabbia dell'uomo per l'ignavia dimostrata dal poliziotto, Cristi lo colpisce in volto.
Intervengono subito i colleghi che lo isolano nella sala svuotata, cercando così di mettere una pezza al suo comportamento, mentre la diatriba tra le due fazioni viene sedata: inizia così il suo viaggio all'interno della psiche del protagonista.
Una storia semplicissima - quasi un semplice episodio - ma che basta al film per portare a termine il suo obiettivo reale: entrare nella percezione di Cristi rispetto la sua omosessualità e mostrare le reazioni degli altri personaggi sul tema.
Una lunga serie di dialoghi e momenti di solitudine scavano nel personaggio di Cristi, che si ritrova confinato in un luogo così emblematico come una sala cinematografica vuota in cui si sarebbero dovuti esser proiettati film legati al mondo da cui cerca di nascondersi (il film proiettato in Camp de Maci è legato all'omosessualità femminile: un cambiamento rispetto alla cronaca dei fatti assolutamente trascurabile).
Il film sa alternare perfettamente momenti più concitati e di discussione con le lunghe attese di Cristi e i tentativi dei colleghi di placarlo: una gestione di ritmi e dialoghi eseguita con grande eleganza e consapevolezza drammaturgica.
La regia di Jebeleanu è molto abile nel creare gli spazi in cui far muovere il discorso psicologico che porta avanti, senza prevaricare con le immagini il flusso emotivo, ma rafforzandolo.
Lasciando al contempo grande spazio al "non detto" e "non mostrato".
In questo si inserisce la capacità di mettere in scena i piccoli cambiamenti della recitazione del protagonista Conrad Mericoffer senza cui il film sarebbe naufragato.
Non è un caso che il grande timore di Cristi sia sempre "cosa sta dicendo là fuori" l'uomo che ha colpito e che non è più nel suo spazio visivo, l'unico su cui sente di non avere il controllo.
A questo percorso introspettivo il film affianca un racconto della Romania del giorno d'oggi, della corruzione che regna in ogni istituzione, della dicotomia sociale rispetto a tematiche importantissime e dei rancori passati che riemergono.
Il formato 16mm è usato in Camp de Maci per rappresentare lo scollamento tra un mondo ancora troppo retrogrado e la voglia di libertà, cultura e cambiamento che deve necessariamente partire dal soggetto e che non può aspettare il mondo attorno.
L'opera prima di Eugen Jebeleanu è una pellicola che fa del suo essere "piccola" la sua forza: rinchiusa in un ambiente e in un personaggio, sa suggerire perfettamente discorsi universali rimanendo fortemente ancorata a una dimensione personale da cui non perde mai il focus.
Uno dei film che ritengo migliori di questa selezione, forse preceduto solo da Sin Señas Particulares e Moving On.
_________________________
Hochwald (Why Not You)
di Evin Romen
Originaria di Bolzano, Evi Romen, cinquantatreenne al suo primo lungometraggio, racconta in Hochwald i drammi personali che le tragedie si portano dietro: nel caso specifico, di come i sopravvissuti a un attentato vedano le proprie vite completamente stravolte.
Mario e Lenz sono amici d'infanzia: il primo, di umili origini, vive ancora nel paese natale e sogna di fare il ballerino mentre il secondo, figlio di una famiglia benestante, vive a Roma ed è un attore in rampa di lancio.
Le vite dei due sono agli antipodi e rappresentano la perfetta sintesi di ciò che Hochwald sembra volere affiancare al racconto dei sopravvissuti, ovvero come ogni tragedia venga vissuta differentemente nel caso in cui si faccia parte della piccola élite fortunata oppure no.
[Mario, uno dei due protagonisti]
Mario subisce le violenze sessuali del fidanzato della madre e vede il suo sogno castrato dalla visione bigotta che un piccolo paese sulle montagne può avere della danza: tutto questo lo conduce nel tunnel dell'eroina.
Dall'altra parte Lenz può vivere liberamente la sua omosessualità a Roma mentre cerca di raggiungere il suo sogno.
Mario segue Lenz a Roma sperando in un'occasione da ballerino, ma mentre festeggiano in un locale gay succede l'imponderabile: dei terroristi islamici irrompono e uccidono gran parte dei presenti, tra questi c'è Lenz e non Mario.
Da questo episodio ha origine il titolo anglofono Why Not You?
È il grido che la madre di Lenz - che non vuole accettare la morte e l'omosessualità non dichiarata del figlio - rivolge a Mario: uno di famiglia, che aveva sempre lavorato nella loro cantina e che ora è il simbolo della sua sofferenza.
Se il western americano ci ha insegnato qualcosa è che quando si è odiati dalla famiglia più facoltosa della città è difficile che gli altri prendano le nostre parti.
In questa condizione di accerchiamento e di sindrome post-traumatica Mario cede ancora di più alla droga.
Vaga alla ricerca di sé e di quel conforto che, alla fine, riesce a trovare in un gruppo religioso islamico che per la prima volta lo aiuta e lo sostiene: la reazione del paesello bigotto che ha appena visto un suo cittadino illustre ucciso dal terrorismo islamico è ovvia.
Il film ha un impianto visivo e registico molto esuberante che alterna colori, movimenti, sguardi in camera e stili differenti, il tutto unito a un uso della musica pop molto insistito.
Una versione acerba, ma che ricorda inevitabilmente l'esuberanza di Xavier Dolan.
Laddove però il regista canadese è ben consapevole del linguaggio estremo che utilizza e riesce sempre perfettamente a fonderlo con la sua visione - molto personale - del mondo e del Cinema, invece Hochwald si perde.
Un contesto esagerato e prorompente compatibile con un'opera prima, ma che proprio in questo linguaggio trova la sua croce: il voler mettere troppa carne sul fuoco non riuscendo a dar spazio e tempo alle intuizioni più convincenti.
Tra un parallelo fra paternità negate (quella di Mario e quello di suo padre), un discorso sul rito e sulla religione, un altro sulla diffidenza dei piccoli borghi e la difficoltà di essere accettati in quanto anticonformisti o, ancora, l'analisi delle sofferenze post-traumatiche, il rapporto con la droga, le situazioni familiari tossiche e un discorso socioeconomico il film di Evin Romen, purtroppo, si perde.
Poiché nessuno di questi elementi - che presi singolarmente avrebbero anche intuizioni interessanti e scelte convincenti - riesce a emergere e la sensazione di trovarsi davanti a tanti temi, buttati lì senza il giusto approfondimento o i tempi che avrebbero richiesto, è davvero grande.
Le idee ci sarebbero anche ma, in una selezione del Torino Film Festival così matura, la differenza con produzioni maggiormente ponderate è facile da notare.
Chi lo ha scritto

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
Lascia un commento

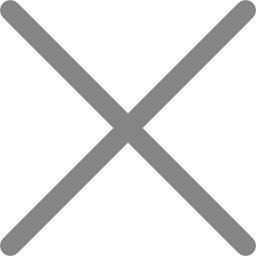
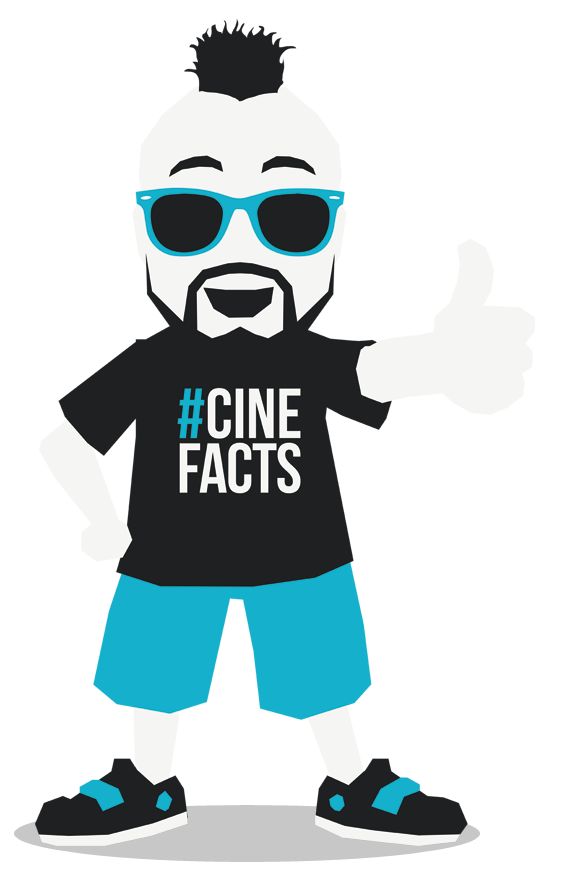

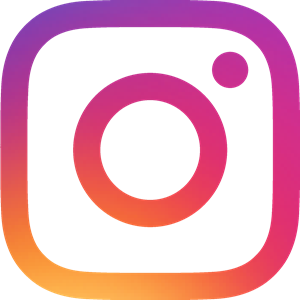






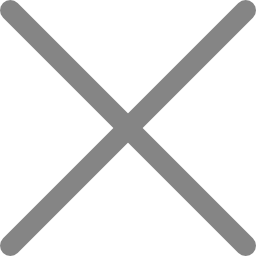
 Commentare gli articoli
Commentare gli articoli