#articoli
Una viaggiatrice a Seoul - Recensione: il cammino delle emozioni
Il giorno in cui l'ovvio cadde nel verde
Da sempre il Cinema di Hong Sang-soo abita sul crinale che divide precariamente degli avvenimenti verosimili da un loro possibile ripetersi, di norma del tutto anti-spettacolare; e Una viaggiatrice a Seoul, Gran Premio della Giuria alla Berlinale 2024, non fa eccezione.
Miracolosamente atterrato nelle sale italiane, con tutta probabilità – come per In Another Country – grazie alla presenza da protagonista di Isabelle Huppert, Una viaggiatrice a Seoul appartiene alla fase più tarda della produzione del cineasta sudcoreano, ormai attestato su una media annua di due lungometraggi e, soprattutto, in carico di ogni aspetto creativo delle proprie opere.
[Il trailer di Una viaggiatrice a Seoul]
Per Una viaggiatrice a Seoul Hong dirige, scrive, compone, produce, monta; il tutto con un ritmo che pare forsennato ma che, invero, tra il budget risicato, la mancanza pressoché totale di pressioni esterne e i pochi giorni di riprese necessari (si veda La caméra de Claire, elemento mediano del trittico con Huppert), collima alla perfezione con un impianto estetico collaudato.
Anche per questo motivo la prospettiva estetica (soprattutto – astraendo – nella componente formale) è stata talora trascurata riflettendo su Hong, un autore che senza dubbio mette al centro le infinite vie della narrazione, spesso con un gusto romanzesco e che, nondimeno, lavora infine sul discorso (anche narrativo) propriamente cinematografico.
In relazione a in water, opera vertiginosa quasi interamente fuori fuoco, teorica e semplicissima, chi scrive aveva tracciato una connessione tra estetica e ontologia (ossia tra estetica e cosmologia) reagendo alla corrispondenza di istanze concettuali e istanze formali.
In quel caso, il trovare un posto esistenziale, accasandosi in una forma di comprensione, combaciava col trovar(si a) posto in un'immagine informe, acquatica.
La ricerca honghiana non si limita dunque al piano del montaggio, alla cui articolazione sintattica sono sovente ricondotti, applicando un punto di vista sin troppo letterario, dei giochi linguistici che riguarderebbero soltanto ripetizioni contenutistiche, narrative; se il montaggio si rivela fondamentale, tuttavia, è in quanto mette esteticamente al lavoro (e in questione) un ordine di natura cosmologica - kosmos significa appunto ordine.
Che cosa voglia dire questa connessione di estetica e cosmologia, forse bizzarra, va ora colto (e testato) in relazione a Una viaggiatrice a Seoul, titolo che peraltro sostituisce un originale che – nella fedele traduzione inglese – suona come A Traveler's Needs. Per farlo, imbocchiamo un sentiero ordinario e forse controintuitivo, quello del resoconto.
Il film si apre in medias res, in un dialogo tra due donne sedute a un tavolo: una è sudcoreana, l'altra è Isabelle Huppert, vestita di verde, le due parlano in inglese, evidentemente una lingua franca. La seconda rassicura subito la prima, che ha un libro tra le mani, e forse dice qualcosa anche a noi: "It'll be easy", sarà facile.
Parlano del libro, ma non si comprende il motivo o chi siano. Il loro discorrere è assolutamente naturalistico, ascoltiamo e vediamo una tranche de vie anti-spettacolare tanto sul versante linguistico quanto su quello cinematografico; se non fosse per la presenza di Huppert (ma anche, com'è ovvio, per il paratesto), potrebbe persino apparire come un documentario.
D'un tratto la donna sudcoreana si alza per suonare il pianoforte; l'inquadratura fissa ancora in essere non la segue, indugiando invece sul(la donna impersonata da) Huppert.
Mentre la osserviamo applicare del nastro verde su una penna, la musica acusmatica che sappiamo provenire dal fuori campo sembra quasi tramutarsi in un commento extra-diegetico, almeno finché una panoramica inattesa segue la transalpina mentre si dirige verso il balcone e, quasi incidentalmente, mostra l'altra donna al pianoforte, che rimane sola.
Piccoli scarti come questo punteggiano Una viaggiatrice a Seoul, parco in quanto a soluzioni tecnico-formali. E già l'immaginario sembra premere sul naturalismo.
Sul balcone, transitando per l'inquadratura sfocata del paesaggio, le due donne conversano di nuovo; nelle pieghe del discorso che si protrae nella passeggiata subito successiva, segnata dall'incontro con le iscrizioni di una pietra commemorativa, affiora in via introduttiva l'istanza concettuale primaria di Una viaggiatrice a Seoul.
Huppert tempesta la dirimpettaia di domande attinenti al suo sentire emotivo, agevolandone l'emersione e la comprensione, e di quando in quando sfodera un taccuino sul quale, con la penna fidata, rielabora in lingua francese – senza compiere traduzioni punto a punto – le risposte che ottiene.
Di chi sono queste domande? Di una psicologa, di un'insegnante, di un'antropologa, di una scrittrice in cerca di ispirazione, di un'amica stramba?
Al termine della scampagnata, colei che domanda riceve del denaro: la relazione è professionale e le due non si incroceranno più.
Il che significa anche che lo spettatore non la incrocerà più (e non le incrocerà più, entro questa relazione).
[Un frame da Una viaggiatrice a Seoul]
Il resoconto prosegue.
Dopo aver pranzato da sola e bevuto makgeolli con gusto, in un frangente che parrebbe drammaturgicamente inessenziale, la professionista – di cui scopriamo soltanto ora il nome: Iris – si reca da una nuova cliente, la sua nuova allieva, giacché in effetti sbarca il lunario come insegnante privata.
È il loro primo incontro, anch'esso all'insegna del makgeolli, e vi partecipa il marito della cliente.
Iris presenta (in inglese) il metodo di lavoro che lo spettatore ha visto in opera: non è davvero una professionista, non ha mai insegnato, ma promette un nuovo tipo di esperienza, trascrivendo in francese le emozioni per mostrare come anche una lingua straniera, sconosciuta, possa esprimere qualcosa di significativo e significante, divenendo perciò propria.
Del resto, la figlia della cliente è lì a testimoniare, nella sua breve apparizione, come il convenzionale approccio scolastico non dia necessariamente dei frutti.
Non è, comunque, il solo motivo dell'apparizione.
Mentre la conversazione si sposta dalla cucina al soggiorno, nello spazio di un taglio di montaggio viene inquadrato un cane tranquillamente accucciato, subito reso oggetto di uno zoom che – ancora, e da segno distintivo del linguaggio honghiano – pare inessenziale.
Quando alcuni minuti dopo la figlia appare, riferendo dapprima dell'inefficacia dei propri studi, è anche per recarsi in veranda a sfamare Nomy, in un'inquadratura consacrata a due figure che lo spettatore – di nuovo – non incrocerà più.
Che strana pistola di Čechov è, a suo modo, questo cane.
Non è un intermezzo insignificante come un paesaggio sfocato, sempre che il paesaggio sfocato – o il paesaggio in genere, che s'insinua in altri tagli – sia davvero insignificante; nemmeno, però, sembra granché significante. Appare per ri-apparire senza un effetto tangibile, senza uno sparo, senza spostare il racconto.
In soggiorno, comunque, chiuso il discorso sul metodo, la cliente sfila al marito la chitarra che ha recuperato per impressionare l'ospite e comincia a suonare; come in precedenza ma senza panoramiche, Iris si dirige verso il balcone esibendo una qualche indifferenza.
Chissà perché la musica (a lei diretta, peraltro) la interessa così poco; oppure – in alternativa – chissà perché preferisce ascoltare le note all'aria aperta, lasciandosi alle spalle chi suona.
Il suo comportamento, in ogni caso, si ripropone, anche se non come una delle ripetizioni tipiche di Hong; una spiegazione razionale, del resto, reggerebbe.
Ma ecco che sul balcone si dipana una conversazione identica a quella iniziale, tanto dal lato di Iris, che usa ancora la penna rivestita di verde perché – dice ora – le piace il colore, quanto dal lato della sua nuova interlocutrice, più problematico in quanto emozionale.
La ragione non tiene.
Due scene oltre si dà un'altra ripetizione, di tono minore: dopo una deviazione di puro riposo e contemplazione al tempio, priva di parole e – come ormai sarà ovvio – inessenziale, i tre s'imbattono in una pietra commemorativa, la seconda, che ospita una poesia e che rilancia, negli inciampi delle traduzioni, il turbinio delle emozioni.
Può allora chiudersi la sessione di insegnamento: Iris intasca il compenso e, nell'intervallo tra due panoramiche manifestamente schematiche, svanisce nel verde del parco, proprio mentre cliente e marito (che lo spettatore non incrocerà più) s'interrogano sul suo passato, senza trovar risposte.
Rimaniamo insomma in medias res quando Una viaggiatrice a Seoul cambia pelle per entrare nel secondo e ultimo segmento, eclissi dell'orizzonte lavorativo.
Nel tardo pomeriggio, dopo aver curato le proprie necessità (needs) economiche, la viaggiatrice torna a casa dal coinquilino poeta e vi rimane fin quando la madre di lui si presenta di punto in bianco e la costringe a uscire, sottoponendo poi il figlio al terzo grado.
Ancora fuori di casa, apolide irredimibile, a Iris non rimane che perdersi nel mondo, nell'altrove, nelle poesie, nel verde.
[Un frame da Una viaggiatrice a Seoul]
Il resoconto si chiude, ma che resoconto è stato? Un resoconto oggettivo, distaccato?
Tante notazioni contenutistiche, una manciata di appunti formali, qualche commento a latere.
È un percorso (ecfrastico) che rende effettivamente conto del film? O dell'esperienza di visione, dal momento in cui il film non si offre che entro questa relazione?
Apriamo una parentesi di riflessione teorica.
La scrittura ecfrastica del resoconto si concatena ad una catena, appunto, di immagini che si danno anche – diciamo provvisoriamente con Roland Barthes – nel proprio senso ottuso.
Noi non siamo che un anello di questa catena, e dalla catena di segni – ossia dal mondo – non si esce, non si può occupare il posto (oggettivante) di Dio.
Nondimeno, dir ciò non implica un mesto ripiego nel soggettivismo; se ciò accade, è a causa della sopravvivenza della dicotomia intellettualistica soggetto/oggetto, che trova una concretizzazione anche nei concetti (saussuriani e poi barthesiani) di significato e significante.
Per quanto feconda, la distinzione del semiologo transalpino tra punctum (privato, emotivo, ottuso, supplementare) e studium (ovvio, codificato, pubblico, generalizzato) non coglie nel segno del problema.
Jacques Rancière, nelle sue elaborazioni sull'estetica, ha invece provato a pensare un'identità di quei contrari, associandola storicamente alla riproduzione tecnica (ma senza determinismi: si veda il riferimento a Schiller, oltre che a Flaubert).
Proprio nella lingua franca per eccellenza, quella della tecnica, ecco offrirsi indissolubilmente – diciamo in maniera generica – un che di vivo.
Ma dove conducono questi rapidi cenni?
Anzitutto, verso un riconoscimento banale: pur non possedendo lo stesso senso ottuso del cinema, il resoconto scritto non è né oggettivo né soggettivo.
Presuppone un investimento emotivo, significativo e significante, anche nella ri-scrittura più diligente; sorge entro una relazione col film e ne rappresenta la condensazione temporanea in un linguaggio ovvio, codificato, pubblico, generalizzato, offrendosi subito alle interpretazioni di chi legge (e, di lì in avanti, non solo).
È una (Una) viaggiatrice a Seoul, in un orizzonte in cui non può darsi la (Una) viaggiatrice a Seoul.
E se diciamo ciò, non è perché la presente ricognizione teorica sarebbe un vezzo di chi scrive, non più – almeno – del consegnare in via esclusiva un resoconto presuntamente oggettivo.
L'ultima fatica di Hong sembra infatti andare in una direzione simile.
Spesso, le inquadrature honghiane appaiono ovvie, se non sciatte; prive di orpelli, paiono subordinate al (montaggio del) racconto, di un'idea, pronte ad essere trapassate, e accantonate, in quanto mimetico-rappresentative.
Connessa in maniera non così lineare alle condizioni produttive menzionate in apertura, la scarsa cura dell'illuminotecnica appare, tra le altre cose, come carattere qualitativamente mediocre, specie nella piattezza complessiva e nei momenti di sovraesposizione.
Hong non calca la mano esasperando e dunque rivendicando quest'approccio, che pure potrebbe richiamare una resa documentaristica (davvero in medias res) e/o naturalistica, di un naturalismo che scansa la bella confezione delle immagini più consuete, ovvie nel loro gusto (borghese) convenientemente innocuo. Ciononostante, la messa al lavoro e in questione di questa dimensione ovvia, franca, di servizio, si rivela centrale.
Le immagini ovvie di Hong anzitutto non scorrono in modo ovvio: combinazioni narrative, ripetizioni e inserti inessenziali lo rendono chiaro, rendendo ogni taglio una voragine, e perciò problematizzando le possibilità significanti della sintassi cinematografica.
Il fatto che, come d'abitudine, i personaggi non comprendano le ripetizioni ma ne siano (a)soggetti, allarga inoltre a dismisura – per noi spettatori che invece siamo consapevoli – il discorso. La loro inconsapevolezza non è accidentale, non deriva soltanto dal troppo bere o da una pennichella; se l'alcol e l'onirico giocano un ruolo, è in quanto relativizzazioni della ragione oggettiva.
Ma l'ordine del mondo sfugge per ragioni più essenziali. Procedendo nel racconto, nel tempo tecnico e inesorabile di un film che si srotola, per noi un qualche ordine emerge, tra curiose pistole di Čechov e legami inattesi.
Per esempio, il colore di una penna diviene importante, uguale a quello di un vestito, di una terrazza, di una foresta, e costringe a reinterpretare il già visto.
Di più: la foresta, il ruscello e la collina che costellano il cammino di Iris sono anche quelli di una poesia, l'ennesima, la terza, che incontra (assieme a una donna che la traduce) vagando lontana da casa. L'immaginario preme, il senso si ispessisce.
E un ricordo torna in vita nel presente, di per sé credibile come analessi ma – contemporaneamente – tessera coerente di un nuovo mosaico.
Anche il passato preme, ma non per imbrigliare.
Del resto, non sappiamo niente di colei che ci guida lungo Una viaggiatrice a Seoul; meglio: non sappiamo niente di quanto è richiesto d'uopo per categorizzare (anche utilmente). Invero sappiamo molto.
Il coinquilino e sua madre discutono di questa mancanza di informazioni: il primo idealizza la straniera, la seconda lo mette in guardia.
Vedendo con occhio esterno, che non è neutro e forse nemmeno così esterno, entrambi hanno le loro ragioni: lui è ammaliato, lei non vuole essere scavalcata e di conseguenza razionalizza.
Al fondo delle due visioni stanno situazioni emotive differenti e Una viaggiatrice a Seoul parla, infine, proprio di situazioni emotive, per impiegare un concetto di stampo heideggeriano.
[Un frame da Una viaggiatrice a Seoul]
Elaborando dal filosofo tedesco, la significatività semiotica – che può accedere alla significanza linguistica – compone un (essere-nel-)mondo, un kosmos, che si dà emotivamente.
Dalla situazione emotiva si avanza, da lì si proviene; e la pro-venienza viene avanti (pro), è sempre messa in gioco, in una ronde cosmologica che propone un ordine ma non è mai immobile. Perciò conosciamo una Iris, perché rispondiamo (emotivamente) al suo fare entro una relazione.
Similmente rispondiamo al mutare imprevedibile dell'opera, che proprio nell'ovvio estetico, lingua franca come l'inglese, custodisce una potenziale ri-apertura.
In questo senso, lo spazio concesso all'emozione mette anzitutto in crisi il disegno delle ripetizioni, che non sono davvero tali per chi le vive (ossia Iris) poiché il mondo è cambiato.
La presa in carico del retroterra emozionale non è – si anticipava – un ripiego nel soggetto.
Il paesaggio e tutto l'inessenziale che costella il cammino di Iris sono davvero le potenziali stelle del cielo; anche se il montaggio è parallelo, l'ingiustificato mostra degli incroci più profondi; incroci che le discese nel verde, come attimi di comunione, sembrano sostanziare.
L'apolide percorre il cammino che la vita le ha donato – dice la seconda poesia; e il cammino è sempre un nuovo cammino – aggiunge la terza.
La vera terra straniera è il più ovvio, la lingua franca (anche cinematografica) in cui adagiarsi comodamente, come a casa. E quanto vi è di convenzionalmente straniero, il francese in Corea o un piccolo scarto, non spaventa se accolto sinceramente; diventa anzi un alloggio provvisorio.
Parlando con la madre, il coinquilino loda Iris in quanto capace di vivere sinceramente.
Precedentemente, rincasata dal lavoro dopo aver tastato la mancanza di poesia, Iris lo aveva incoraggiato a poetare e lo aveva ascoltato – lui sì – suonare la pianola.
Nell'ascolto, aveva formulato poi un consiglio: resisti alla tentazione di procedere mnemonicamente, automaticamente, e rispondi invece ad ogni nota.
Vivere sinceramente equivale a rispondere ad ogni nota emotiva, a vivere poeticamente, senza contentarsi dell'ovvio.
In Una viaggiatrice a Seoul, questo vale anche per lo spettatore, implicato nella connessione tra estetica e cosmologia, chiamato a interpretare quanto è ovvio solo per un occhio distratto, chiamato a prendere sul serio le metamorfosi del cammino interpretativo.
Scrive Friedrich Nietzsche, opponendosi a Marco Aurelio e con un pensiero, quello dell'eterno ritorno, da intendere eticamente, come postura esistenziale:
"Quell'imperatore tenne sempre presente la transitorietà di tutte le cose per non dargli troppa importanza e restare tranquillo in mezzo a loro.
A me pare invece che tutto abbia troppo valore per poter essere così fuggitivo: [...] si devono forse gettare a mare gli unguenti e i vini più preziosi?
La mia consolazione è questa: tutto ciò che fu è eterno, il mare lo rigetta sulla riva".
Facile, no?
___
CineFacts non ha editori, nessuno ci dice cosa dobbiamo scrivere né come dobbiamo scrivere: siamo indipendenti e vogliamo continuare ad esserlo, ma per farlo abbiamo bisogno anche di te!
Chi lo ha scritto

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
Lascia un commento

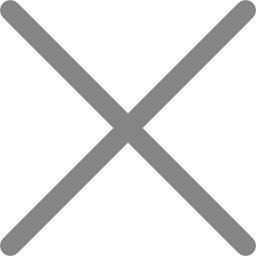
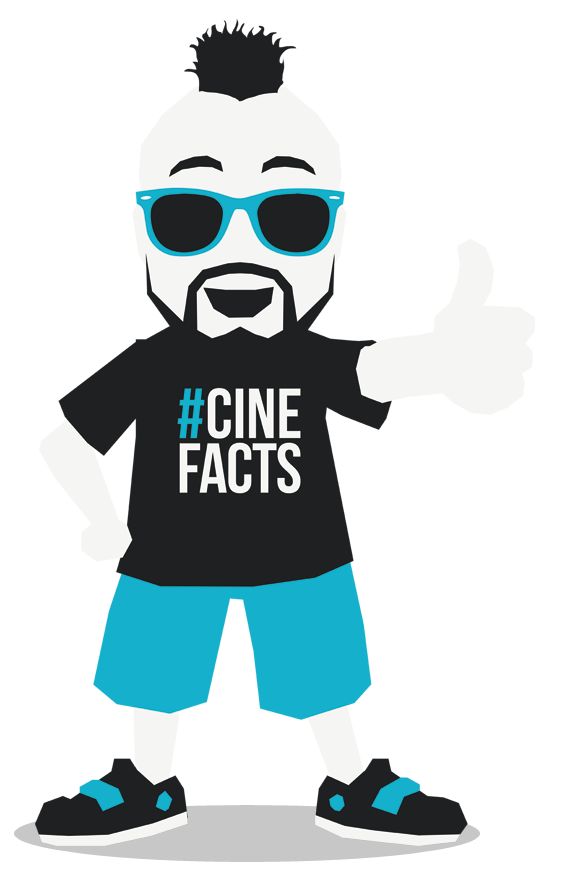

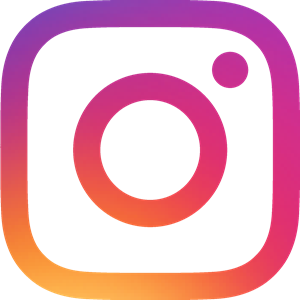






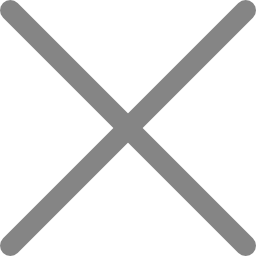
 Commentare gli articoli
Commentare gli articoli